Galileo Chini pittore europeo
di Fabio Benzi
Introduzione
Un anno
dopo la grande retrospettiva alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna, che ha definitivamente messo a punto una rinnovata
quanto corretta lettura dell’opera dell’artista,
collocandola definitivamente in un contesto europeo di largo
respiro che gli compete strettamente, presentiamo questa più
piccola esposizione privata, composta di una ristretta ma
significativa selezione di opere, centrate (anche se non esclusivamente)
sulla significativa esperienza siamese (1911-13).
 |
| Galileo Chini in una foto di Numes
Vais, 1904 c.a. |
Da diversi anni, studiando
sempre più a fondo la figura di questo grande artista,
ci si è resi conto di quanto la sua dimensione espressiva
fosse decisamente singolare rispetto a molti dei suoi colleghi
italiani contemporanei, nutrita di un cosmopolitismo robusto,
non superficiale; e parimenti dotato di una foga creativa
che ne fa una delle incarnazioni europee più complete
dell’artista universale individuato dall’ideologia
modernista dell’Art Nouveau (che è poi alla base
delle teorizzazioni delle Avanguardie storiche) e al tempo
stesso un pittore intimamente quanto autonomamente legato,
fin dal secondo decennio del secolo, a una tendenza post-impressionista
incarnata, nel Novecento, da artisti come Bonnard e Vuillard.
La sua posizione culturale,
naturalmente internazionale nella sostanza e nella vocazione,
era stata temporaneamente messa in ombra, nella seconda parte
della vita, da un’aristocratica solitudine, da un’appartata
distillazione delle sue energie pittoriche, che ne ha fatto
in un passato ancora prossimo fraintendere o dimenticare la
profonda consonanza con esperienze europee di enorme spicco,
ma che in Italia, per ragioni che non staremo qui ad indagare
(certo soprattutto per un gusto classicheggiante dominante
nel periodo tra le due guerre, cui Chini era nettamente estraneo),
non hanno avuto particolare diffusione e dunque riscontro.
Se in un passato ancora piuttosto
recente – fino agli anni Settanta del Novecento –
le etichette di pittore liberty o ancora più genericamente
post-macchiaiolo sembravano sufficienti a definire l’opera
di Chini (per quanto fossero profondamente scorrette e fuorvianti),
ciò avveniva poiché erano forse le uniche griglie
di analisi critica che in Italia potevano allora essere comprese;
oggi invece la sua figura si può più ampiamente
valutare se inserita nel contesto tipicamente novecentesco
di un’ “impressionismo psicologico” che
in Europa e in America fece proseliti tra artisti grandissimi,
come Bonnard, Vuillard, lo stesso Matisse, Corinth, Prendergast,
Grant, Moll, ecc., mentre in Italia fu appannaggio di personalità
originali ed eccentriche, disparate e spesso, come fu per
Chini, fraintese o sottovalutate: come De Pisis, Semeghini,
Tosi, Cavaglieri, ecc.
La storia
artistica di Chini inizia nell’ultimo decennio del XIX
secolo: nasce, ancora giovanissimo, come decoratore nella
Firenze eclettica di fine secolo, allievo di Augusto Burchi,
ma già nel 1896 si emancipa da quel gusto tradizionale
per proiettarsi vivacemente nel dibattito modernista europeo,
divenendo con la sua poliedrica e simultanea attività
di pittore, affreschista, grafico, scenografo, ceramista,
il personaggio leader del nuovo gusto in Italia, quello, come
s’è detto, che interpreta più compiutamente
le istanze universaliste, l’abbattimento delle barriere
tra arti maggiori e minori tipiche dell’Art Nouveau
e poi delle avanguardie. In particolare, le sue creazioni
ceramiche sono certamente uno dei massimi apici di quel gusto
in Europa. I suoi ripetuti successi alle Biennali di Venezia,
le sue partecipazioni e i premi ottenuti ad innumerevoli esposizioni
internazionali a partire dal 1898, lo consacrano come uno
dei più versatili artisti italiani di quell’epoca.
Personaggio piuttosto atipico, come già s’è
detto, rispetto all’ambiente artistico italiano, egli
aveva trasgredito le imperanti regole accademiche dedicandosi
ad espressioni fino a quel momento considerate “minori”
seguendo una spinta istintiva verso principi di rinnovamento
e di modernità espressiva, nutrito dalle idee moderniste
europee (in particolar modo attento alle teorie inglesi degli
“arts and crafts” e alle innovazioni linguistiche
delle secessioni mitteleuropee).
 |
| Galileo Chini davanti al quadro La
sfinge, 1903 |
Il concetto
che non esistessero distinzioni espressive nelle varie pratiche
artistiche, aveva avuto nell’ambiente tradizionalista
italiano pochi precedenti, tutti inseriti nella preziosa nicchia
di una Roma Bizantina e legata a Gabriele d’Annunzio
(Cellini, Ximenes, De Carolis), e sottoposti a un concetto
élitario della realizzazione che li rendeva raffinati
contorni di un ristretto circolo decadente. Chini promuove
invece un concetto dell’opera d’arte di produzione
industriale, di ampia diffusione, con una fortissima incidenza
nei costumi e nel gusto quotidiano: le sue ceramiche sono
prodotte in grande quantità e introducono nelle case
borghesi un gusto art nouveau inedito per l’Italia fino
a quel momento, così come le sue decorazioni parietali
escono dalle chiuse ambientazioni di case di intellettuali
adepti di un gusto modernizzante, per diffondersi in ambienti
pubblici (sedi di banche, alberghi, teatri, esposizioni temporanee),
caratterizzando le sedi di incontri sociali e quotidiani,
invadendo i luoghi della vita e determinandone il gusto con
una decisione fino ad allora sconosciuta. Queste teorie verranno
esposte in un Manifesto che Chini scrisse nel 1917 (Rinnovando
rinnoviamoci), nel quale si proponeva l’abolizione delle
Accademie di Belle Arti che con la loro struttura sancivano
la distinzioni tra arti maggiori (pittura, scultura e architettura)
e minori, e l’istituzione di “Scuole artistiche
industriali atte a rinnovare tutte le forme delle arti applicate”.
In pittura egli aderisce
fin dagli esordi al divisionismo, coniugandolo con uno spirito
nettamente simbolista, in una direzione espressiva e stilistica
tipicamente italiana, impostata dai più anziani Segantini,
Pellizza da Volpedo, Previati e Nomellini, gli artisti allora
più ricercatamente moderni; Chini dipinge scene con
soggetti simbolici e allusivi (Le Frodi, Icaro, Medusa, La
Sfinge, Il Trionfo), paesaggi di inquietante emotività
interiore, ritratti in cui la ricerca psicologica viene accentuata
da ambientazioni notturne e corrusche. Pur inserendosi nel
clima ancora fervido del decadentismo internazionale (imperniato
sulle figure di Rodin, Besnard, Klimt, Von Stuck, Toorop,
Hodler, ecc.), Chini propone una versione originale di quel
linguaggio filtrandolo attraverso un divisionismo libero e
filamentoso, che rappresenta a quell’epoca il mezzo
espressivo “moderno” per eccellenza: antinaturalistico
e riflessivo, è un filtro che impedisce naturalmente
qualsiasi accento veristico o accademico, asserendo il valore
concettuale e non puramente rappresentativo dell’opera
d’arte. Una vocazione alla modernità, la sua,
così estroversa da trovare una sponda persino nel giovane
Boccioni – anch’egli divisionista, che nella formazione
del suo futurismo troverà modo di meditare, oltre che
su Previati, anche su alcuni brani della cupola dipinta da
Chini alla Biennale di Venezia nel 1909.
Quando Galileo
Chini, nel giugno del 1911, si imbarcò a Genova sul
piroscafo diretto a Bangkok, era già un pittore di
enorme successo, noto internazionalmente e appena trentasettenne.
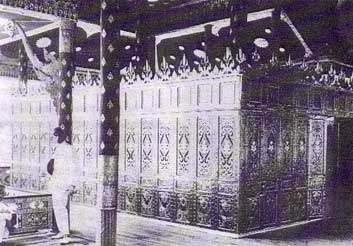 |
Galileo Chini al suo arrivo a Bangkok
in una sala del palazzo reale, 1911 |
Il soggiorno
siamese si colloca dunque al culmine del successo dell’attività
chiniana, in un momento di grande produzione soprattutto di
decorazioni parietali: del 1909 è la decorazione della
cupola della Biennale di Venezia, del 1910 quella del padiglione
italiano all’Esposizione Internazionale di Bruxelles,
del 1911 il grande fregio per l’Esposizione Internazionale
di Roma (circa 3 metri d’altezza e 80 di lunghezza).
Benché Chini ricordi nelle sue memorie che il re Rama
V, vedendo gli affreschi della cupola alla Biennale di Venezia
del 1909, decise con un piglio da sovrano assoluto di affidare
al pittore gli affreschi dell’Ananta Samakhom Throne
Hall (“Ho trovato e voglio questo pittore Italiano per
decorare il Phra-Ti-Nam”), in effetti l’episodio
va riferito alla Biennale del 1907, dove Chini allestì
e decorò la “Sala del Sogno”, e dove il
sovrano effettivamente si recò durante il suo secondo
e ultimo viaggio in Europa, accompagnato da dignitari di corte
e dall’ingegner Carlo Allegri (Direttore Generale del
Dipartimento dei Lavori Pubblici del Siam) e dall’architetto
Annibale Rigotti, autore del progetto della Sala del Trono.
I lavori del Palazzo del Trono non erano dunque ancora iniziati
(il palazzo fu costruito tra il 1909 e il 1911), ma solo pianificati,
quando Chini venne contattato e successivamente definitivamente
ingaggiato, nel 1910, per questo monumentale lavoro per il
quale gli venne corrisposta l’ingente somma di 100.000
lire. La suggestione orientale ebbe dunque tempo di formarsi
e sedimentare nell’animo di Galileo Chini, che già
dall’inizio del secolo era attratto dagli elementi decorativi
orientali che riproponeva e reinterpretava nelle ceramiche:
queste suggestioni si amplificano soprattutto nella produzione
ceramica dopo il 1907, e un più forte e marcato linearismo,
che racchiude i contorni delle figure prima piuttosto sfumati,
emerge anche nelle decorazioni parietali pur senza citazioni
dirette di motivi orientali.
La lunga incubazione di un
viaggio in terre lontane e favolose dispose con evidenza Chini
a un’evoluzione del suo linguaggio pittorico. Il fascino
dell’esotismo, che da un secolo continuava a far sognare
gli artisti europei e che per molti rimaneva un sogno irrealizzato,
aveva avuto alla fine del XIX secolo e all’inizio del
XX un ultimo momento di enorme attrazione: da Gauguin ai pittori
di Pont-Aven, da Debussy a Puccini, da Klimt a Nolde, le suggestioni
e, più raramente, i soggiorni nei paesi esotici avevano
creato nostalgiche e appassionate adesioni artistiche, avevano
suggestionato e innovato il linguaggio occidentale dell’arte,
aprendolo a lussureggianti aneliti cromatici, a forme di linearismo
inedito, ad atmosfere di rarefatta interiorità.
Nei ricordi di Chini del
viaggio e del soggiorno in Siam traspare questo senso di meraviglia,
che in lui si accorda a uno spiritualismo di matrice teosofica
che nell’osservazione del buddismo trova nutrimento
e suggestione. Il viaggio in nave procede da Genova facendo
tappa a Porto Said, Suez, Aden, Colombo, Penang e infine Singapore,
dove cambia battello per arrivare a Bangkok. La meraviglia
dell’oriente comincia a manifestarsi nella tappa di
Colombo, che visita insieme alla nipote del pittore preraffaellita
Watts: “Colombo, città veramente da ‘Mille
e una notte’. Quando scendemmo a terra era già
buio: il plenilunio era abbagliante, i muri bianchi delle
abitazioni, caratteristici per la loro struttura, diventando
d’argento, la vegetazione superba rifletteva una luce
di smeraldo, l’aspetto e il portamento delle persone
erano per noi fonte di strana e misteriosa meraviglia. Il
mercato, con frutta e cose fino allora a me sconosciute, mi
fece una strana impressione. Mi si riaffacciarono alla mente
alcune cose che avevo letto su Budda ... ed allora alcuni
aspetti non mi parvero più nuovi”. Del Tempio
Celeste di Colombo esiste un piccolo dipinto realizzato sul
posto da Chini, che per la poetica scioltezza introduce già
a un nuovo e originale modo di percepire e rappresentare la
realtà.
 |
Galileo Chini a Bangkok,
in costume siamese, 1912 |
All’arrivo
a Bangkok lo aspettano emozioni e sorprese ancora più
grandi, come l’incoronazione di re Rama VI, i cui festeggiamenti
fastosi furono la base per gli affreschi della Sala del Trono:
“A chi vi giunge per la prima volta, il Siam suscita
una impressione strana [...] Certo è che in quei giorni
(durante le feste) si offrirono ai nostri occhi spettacoli
veramente allucinanti [...] Quei templi dalle mura bianche,
dalle porte in oro, dalle finestre in mosaico vetrario e di
madreperla, dai tetti in ceramica policroma e dorata, sostenuti
mediante ossatura di legni preziosi o laccati, con Budda e
con Santi di bronzo dai colori di patina fosforescente, con
statue di stranissimi simboli, per noi incomprensibili, sono
cose che oltrepassano ogni descrizione. Gli elefanti sacri
coi loro mascheramenti religiosi, i loro palanchini, le loro
torrette, gli uomini che nei costumi sfarzosi li guidano o
sopra di essi rappresentano figure leggendarie o religiose
o militari o civili, non sono affatto cancellati dal mio ricordo
[...] Le feste proseguirono per parecchi giorni, e così
anche noi europei avemmo modo di addentrarci un po’
in quello che è il vero spirito dell’Oriente.
Per me fu cosa utilissima, che dette modo al mio spirito di
mettermi nella condizione più opportuna per eseguire
il mio lavoro, e le rappresentazioni che dovevo illustrare
furono da me eseguite in modo tale da destare l’approvazione
e l’ammirazione del Re e degli esperti di Corte”.
Nei primi
bozzetti e dipinti eseguiti in Siam emerge una grande libertà
formale, un’uscita dal clima e dai soggetti simbolisti
tipici del primo decennio del secolo, e una naturale propensione
a cogliere gli aspetti lirici, intensamente emotivi della
realtà. Il divisionismo, già piuttosto liberamente
interpretato nel decennio precedente, si scioglie in una pennellata
autonoma, in colori “di patina fosforescente”
accostati con una libertà compositiva che fa echeggiare
risonanze interiori, effetti di memorie evocate e risvegliate.
Inizia per Chini un nuovo periodo, post-simbolista, che mostra
(come già si è detto) una singolare analogia
con quello di Bonnard, Vuillard e gli altri pittori già
del gruppo dei “Nabis”, che nel nuovo secolo abbandonano
anch’essi le matrici simboliste per entrare in uno scavo
della realtà scoperta nelle sue risonanze “interiori”.
I quadri eseguiti nel 1911 e all’inizio del 1912 sono
paesaggi intimi e luminosi, animati da accensioni e bagliori
misteriosi (Il mio cortile a Bangkok). Il Tifone, osservato
durante il viaggio in nave, è un dipinto che ancora,
nell’incombente massa delle nuvole squarciata dal sole,
mostra un deposito simbolico del passato, ma ormai l’emozione
derivante dal fenomeno naturale ha preso il sopravvento sul
simbolismo esplicito dei dipinti precedenti. Gli interni dei
templi in penombra, animati di fiammelle fatue, in cui la
meditazione dei fedeli è come un’esalazione spirituale
dominata da Budda immensi dai bagliori d’oro, le vedute
di canali al tramonto, di notturni stellati, di templi immersi
nella foresta tropicale, sono dipinti tra i più lirici
e poetici della pittura internazionale di quegli anni. Le
figure orientali ed enigmatiche di danzatrici, di malinconici
mandarini cinesi raffigurati tra i vapori degli incensi, con
un tessuto pittorico sfibrato dall’emozione e dalla
nostalgia, sono immagini di un mondo lontano eppure fisicamente
presente, da cui emerge un pathos contenutissimo eppure lancinante.
Appena arrivato
a Bangkok l’artista inizia a studiare le rappresentazioni
della Sala del Trono: naturalmente le cerimonie per l’incoronazione
del nuovo re Rama VI gli sono di enorme suggestione per la
definizione degli apparati iconografici, delle situazioni,
per lo studio dei costumi di gala. Risalgono infatti a questo
periodo iniziale una serie di studi a grandezza naturale,
a tempera su tela o su cartone (più raramente a olio),
di personaggi di corte nei loro sfarzosi costumi: studi nei
quali traspare la luminosità di un colore inedito finora,
dalle opalescenze nate dalla luce e dalla vivezza delle tinte
tropicali.
Chini mette immediatamente
“mano alla decorazione della cupola e del suo piedritto
e così giunsi a prepararmi a quanto m’occorreva
per il rimanente dell’opera mia, specie per la rappresentazione
dell’Incoronazione del nuovo Re a cui io potei assistere,
che mi fu una facilitazione utilissima dato anche certe difficoltà
che il rito esigeva e oltre a questo ebbi grande fortuna di
poter comprendere, nei fastosi e nei sontuosi orientalismi,
favolosi per noi Europei, a cui non poteva arrivare il mio
discernimento a noi tanto lontano”.
Spesso trascurato dalla critica,
si colloca a questo punto un significativo viaggio che Chini
compie nel 1912, tornando per qualche tempo in Italia a causa
di una malattia che aveva colpito sia la moglie che il cugino
Chino, responsabile durante l’assenza di Galileo della
conduzione della Manifattura ceramica. Non sappiamo quanto
durò questo soggiorno, ma nel tempo che Chini trascorse
in Europa, egli mise a punto un’ulteriore maturazione
artistica: certamente si aggiornò sulle novità
europee realizzatesi durante la sua assenza, certamente imbastì
in quell’occasione la sua partecipazione alla Biennale
del 1914 con una sala di opere siamesi, e probabilmente, come
gli era consueto, si recò anche all’estero: si
spiegherebbe così una singolare vicinanza strutturale
tra un’opera di Klimt presentata all’Esposizione
d’Arte di Dresda nel 1912, il Viale nello Schloss Kammer
Park, del 1911-12, e un dipinto eseguito probabilmente subito
dopo il ritorno in Siam, Canale a Bangkok, anch’esso
del 1912, anche se egli aveva già impostato il tema
in una scenografia per Sem Benelli del 1910.
 |
| Sala Mestrovic, Biennale di Venezia
del 1914 |
Al ritorno
in Siam emergono infatti nella pittura di Chini distinti accenti
secessionisti, seppure integrati in una visione magica, lussureggiante
dell’oriente: il carattere di questi dipinti è
nostalgico, liricamente - quasi puccinianamente - declamato,
liberissimo di esecuzione. Il quadro cardine di questo secondo
periodo siamese è La festa dell’ultimo giorno
dell’anno cinese a Bangkok (1912): dipinto enorme, è
un rutilante sogno orientale, in cui la moltiplicazione dei
punti luce, la compenetrazione dei riflessi cromatici, possono
ricordare analoghe soluzioni boccioniane, dalla Rissa in Galleria
a La città sale, a Idolo Moderno (alcuni di questi
e altri quadri furono forse visti da Chini a Milano nel 1910,
o conosciuti attraverso riproduzioni durante il soggiorno
a Firenze del 1912). Certo, i profili semplificati e corrosi
dalle luci colorate dei personaggi, la presenza inquietante
e pirotecnica del drago cinese, realizzati con paste di colori
contrastanti, sono di una resa espressiva originale e inconsueta,
quasi una visione filtrata da un’esperienza oppiacea,
e costituiscono uno degli episodi più alti e singolari
della pittura italiana di quegli anni.
In campo
pittorico Chini realizza dunque in oriente una visione ormai
personale e matura di un post-impressionismo libero e psicologicamente
caricato, che abbandona definitivamente le residue cadenze
simboliste per proiettare invece l’interesse sul contenuto
psicologico dell’immagine, sulla permanenza dell’emozione
nella vibrazione del colore e nella scelta del soggetto, in
cui, modernamente (e potremmo dire proustianamente) si sostituisce
alla percezione fisica dell’occhio quella soggettiva
ed emozionale della memoria e dello “stream of consciousness”,
della percezione prolungata nella coscienza che viene teorizzata
in filosofia, negli stessi anni, da Bergson.
Se questa nuova ed originale
visione artistica ed estetica di Chini risulta tra 1912 e
1913 originalmente intersecata da suggestioni secessioniste
viennesi, nei lavori ad affresco mantiene invece un tono “ufficiale”
alto, più evidentemente legato alle precedenti esperienze
dell’artista in campo murale, seppur fantasiosamente
intersecato da lussureggianti cromatismi e da orientalismi
evidenti. Tuttavia, nell’esecuzione degli affreschi,
il suo orientalismo non deriva solamente (come nei dipinti)
da una suggestione psicologica profonda, ma soprattutto da
una posizione estetica precisa, citata nelle Memorie e nello
stesso manifesto “Rinnovandoci Rinnoviamo”: la
volontà di riportare i “caratteri etnografici”
tipici del luogo in cui si lavora (“Per questo dovei
visitare monumenti di varia indole e procurarmi da questi
e da altre cose, conoscenza di quei materiali necessari a
farmi una discreta conoscenza Etnografica necessaria, oltre
che la parte storica dei soggetti che dovevo svolgere”
. Tra i principi sostenuti dal manifesto “Rinnovandoci
Rinnoviamo” (1917) vi era lo “Sviluppo di tutte
le applicazioni artistiche derivanti da caratteri etnografici”),
simbolo di una dignità “colta” dell’opera
d’arte, di una qualità di pensiero e di “verità”
che egli attribuisce alla rappresentazione artistica, scevra
ormai dei cascami estetizzanti del simbolismo fin de siècle.
 |
La sala della XXV Biennale di Venezia
del 1914
con la personale di Galileo Chini |
Di fatto
gli aspetti maggiormente “orientalisti” degli
affreschi si colgono nelle zone non figurate, decorate con
elementi siamesi, e nelle descrizioni degli abiti e delle
cerimonie, fedelmente riprodotti attraverso uno studio approfondito.
Il tono generale delle composizioni, che si lega peraltro
allo stile generale del Palazzo del Trono, di un eclettismo
internazionale e ben poco orientaleggiante (la scelta del
re era infatti di avere dei manufatti decisamente in stile
“europeo”), rimane invece, come si accennava,
quello tipico di Chini, e di un genere di rappresentazione
storica e “popolare” (nel senso di penetrazione
dell’epos di un popolo) che trova ad esempio nello svizzero
Hodler (come ebbe a notare Anna Imponente) analoghi caratteri
di fedeltà storica misti a una visione stilisticamente
antinaturalistica, rutilante, segnata linearmente e cromaticamente
secondo i moderni stilemi dell’art nouveau.
Il ritorno
di Chini in Italia avviene nell’estate del 1913. Il
frutto di questa impareggiabile esperienza confluirà
nella sala di dipinti siamesi che l’artista presenterà
alla Biennale di Venezia del 1914, e parimenti nella celebre
serie di pannelli concepita per la sala Mestrovic alla stessa
Biennale, in cui le astrazioni formali orientaleggianti incrociate
ai secessionismi viennesi gli permettono di esprimere il flusso
rigoglioso e naturale dell’esistenza: in cui anche il
soggetto, La Primavera che perennemente si rinnova, riassume
il senso di misticismo panico che l’oriente gli aveva
donato, attraverso l’inedita sensibilità spirituale
del buddismo.
| Chini
tra le due guerre. La solitudine come appartata distillazione
di temi |
|
In Italia,
parallelamente a quanto avveniva in Europa sebbene in misura
più ristretta, va delineandosi fin dal principio del
secolo una tendenza pittorica originale, che può definirsi
“impressionismo psicologico”, che intendeva sostituire
alla realtà e all’impressione ottica ed empirica
ottocentesca un diverso modo di rispecchiare il mondo, ribaltando
sull'impressione soggettiva e psicologica il contenuto dell'immagine
pittorica. Tale esigenza, nutrita di un sentimento “bergsoniano”
del tempo e della psicologia, traccia un'ipotesi di espressione
"moderna" alternativa alle avanguardie, in continuità
ed evoluzione rispetto alle esperienze impressioniste e simboliste.
 |
Galileo Chini davanti alla Manifattura
a
Borgo San Lorenzo, 1920 |
Galileo
Chini è certamente il pittore più significativo
ed emblematico in Italia di questa tendenza che ribalta l'impressione
ottica sulla coscienza interiore, una sorta di parallelo italiano
a Bonnard. Il triennale soggiorno in oriente sviluppa in Chini
la vena meditativa e di trasfigurazione della realtà
in ritmi cromatici sottilmente virati, in immagini permeate
da un trasporto interiore non frenato, che libera le paste
pittoriche alleggerendole in tocchi divisionisti che registrano
non la divisione del colore ma la permanenza nella coscienza
di un bagliore, di una sensazione.
Il monologo interiore, lo
spirito sensibile aperto ad ogni circuitazione dell'intelletto
e della sensibilità, sono le costanti dei quadri di
Chini, come di quelli dei suoi corrispettivi europei: Bonnard
e Vuillard in Francia, Grant in Inghilterra, Corinth in Germania.
La loro libertà formale, che non vuole costringersi
in forme o concetti progettati e organizzati, precostituiti,
deriva da una profonda libertà intellettuale, da una
capacità di abbandonarsi alle onde della coscienza
interiore.
Galileo Chini, dopo i grandi
successi internazionali del primo decennio del secolo, sviluppa
sempre più un carattere che lo conduce alla scelta
solitaria della pittura, abbandonando quasi definitivamente
le grandi imprese decorative ad affresco che tuttavia conduce
ancora negli anni Venti, in cicli che lo confermano uno dei
migliori interpreti del Déco italiano. Nel 1930 tiene
una grande personale alla galleria Bernheim-Jeune di Parigi,
la maggiore galleria europea che presentava questa tendenza,
e prosegue l'attività pittorica dipingendo in appartata
solitudine una serie di paesaggi della Versilia, di nature
morte, di nudi di straordinaria felicità pittorica,
di un intimismo lirico altissimo e sensualmente melanconico.
Si apre una stagione, che ha il suo epicentro negli anni Trenta,
di larga e continua produzione, che dura fino alla Seconda
guerra mondiale, epoca in cui il mondo sembra incrinarsi per
l’ormai anziano pittore, che non riconosce ormai più
la possibilità felice di un isolamento psicologico,
sconfessato dalla cruda realtà della guerra.
Nel secondo dopoguerra la
sua pittura infatti si scurisce, arrivando a esiti espressionisti,
per terminare la sua carriera pittorica in un cupo simbolismo
che recupera temi della sua gioventù, resi drammatici
dalla progressiva perdita della vista e dalla prossimità
percepita della morte.
|